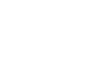
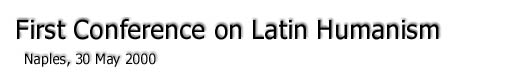
Our Purpose
Forthcoming Events
Program
Papers
List of Participants
Related Sites
Press Release
verso una sintesi e un programma
Intervento conclusivo del Prof. Rocco Caporale (St.John's University, N.Y.)
Convegno su "Globalizzazione e Umanesimo Latino"
New York 1-3 maggio, 2000
A conclusione del dibattito di questi giorni, dobbiamo riconoscere che, in appena tre anni, il movimento culturale promosso dalla Fondazione Cassamarca sotto la guida del suo Presidente, l'On. Avv. Dino De Poli, ha fatto dei passi da gigante.
E' in forza di questo progresso che, dopo sei convegni internazionali preparatori, celebrati negli ultimi due anni, ci siamo ritrovati qui a New York in questo simposio allo stesso tempo riepilogativo e programmatico.
Appare chiaro che, per la prima volta nella storia recente, l'iniziativa De Poli va ponendo le basi per la globalizzazione del mondo latino; e per questo a nome di tutti i popoli latini vogliamo esprimergli la nostra sincera riconoscenza.
Gli interessantissimi interventi preparati per questo convegno da un centinaio di partecipanti, a cominciare dai rapporti continentali, e riprodotti nei tre volumetti distribuiti, sono prova indiscutibile che questa iniziativa sta avendo successo e produce frutti positivi.
Non accade ogni giorno che oltre 150 studiosi provenienti da sei continenti, trenta nazioni e cento università affrontino con grande maturità e competenza il difficile e inconsueto tema del rapporto tra Umanesimo Latino e Globalizzazione, con interventi ben meditati e con un dibattito a volte molto acceso.
In questa seduta conclusiva il mio compito e' fare il punto sulla situazione, e delineare le direttrici e gli orizzonti che sono davanti a noi, la nuova frontiera concettuale del movimento umanesimo latino per i prossimi anni.
Non occorre rifare il cammino etimologico delle due nozioni del tema di questo convegno: ai fini di un discorso produttivo, consideriamo come acquisito e condiviso, anche se solo intuitivamente, il significato, o la gamma di significati, dei due concetti fondamentali: Umanesimo Latino e Globalizzazione.
Su questi due concetti potremmo indulgere in un esercizio euristico ed etimologico di limitata utilità, oppure, alla McLuhan, potremmo porci le cinque domande classiche della ricerca scientifica: dal punto di vista umanistico latino, chi globalizza?, che cosa?, in che modo?, per il beneficio di chi? e con quali conseguenze?
Mi sia permesso, invece, di ricapitolare l'articolazione delle idee principali e delle immagini che in questa aula ci siamo scambiate e sulle quali abbiamo dibattuto, di identificare alcune delle dinamiche concettuali che sono state sprigionate da questo convegno, per poi aprire sulla panoramica delle direttrici sulle quali potremmo muoverci nei prossimi anni.
Mi colpisce il fatto che una buona parte degli autori dei saggi non si sono negati il piacere di castigare il modo in cui la globalizzazione viene finora concepita ed attuata. Siamo stati quasi tutti d'accordo nella necessità di fustigare intellettualmente gli economisti (o almeno alcuni di loro), il multinazionalismo corporativo, e l'arroganza egenomica anglosassone.
Ma forse abbiamo abbaiato nella notte come cagnolini nella direzione di ombre. Perche', purtroppo, tra di noi non ci sono molti rappresentanti sia della malvista ideologia neo-economicista, sia dei grandi interessi corporativi che oggi guidano la globalizzazione e sia dei leaders politici che sostengono la globalizzazione ignorando i suoi risvolti umani.
I grandi assenti da questo convegno, gli economisti, i gestori delle multinazionali e i politici, sono quelli con cui dobbiamo confrontarci, se non vogliamo trastullarci tra di noi, ma arrivare a una valida soluzione.
La maggior parte degli interventi ci ha giustamente cautelato contro i pericoli della globalizzazione. Il prof. Carsaniga allude a coloro che vedono la globalizzazione come una "ideologia perversa", mentre il prof. Carlos Pimenta vede nella globalizzazione il "contro-umanismo".
Ma non e' mancato un consenso incoato che intravede per la globalizzazione una funzione positiva nel fatto che l'umanesimo latino si candida a redimere il globalismo dalle sue gravi pecche, un merito che noi generosamente ci auto-conferiamo, anche se la nostra convinzione non e' necessariamente condivisa dai nostri colleghi universitari dei dipartimenti di economia, scienze della finanza o business administration, come hanno ben illustrato nel loro saggi il prof. Denis Menjot, il prof. Robert Viscusi e il prof. Gilardino.
A conti fatti, restano tre domande largamente inevase, nascoste nelle pieghe del discorso, cosi' come si e' venuto sviluppando in questi giorni:
1.la globalizzazione rappresenta un pericolo o una opportunità per la società civile?
2.a quali condizioni puo' l'umanesimo latino riuscire a evitare il pericolo e avvantaggiarsi dell'opportunita'?
3.come mai l'Umanesimo Latino ha permesso che una cultura economicista e consumerista prenda il sopravvento sulla solida tradizione economica di due millenni di progresso umanistico?
Il prof. Bresolin, nel suo erudito saggio, ha documentato il contributo fondamentale del pensiero neolatino alla scienza economica moderna. In base a questo attivo storico, sarebbe miope non discernere che oggi il processo di globalizzazione offre all'umanesimo latino opportunità senza precedenti di affermare e diffondere i principi fondamentali sviluppati e promossi nei secoli passati.
Nel rapporto continentale per il Nordamerica, il prof. Sergio Gilardino ha giustamente rilevato che i fondatori della repubblica americana erano umanisti di altissimo livello, che riuscirono a forgiare la costituzione americana nel crogiuolo del loro umanesimo classico. Come si spiega la trasformazione di questa nazione di pionieri dall'umanesimo dei padri fondatori al gretto materialismo ed efficientismo economico dei yankee di oggi?
Quali ambiguità, lacune o scarsezze nell'umanesimo latino l' hanno estromesso al di fuori del progresso economico delle nazioni?
E allora occorre che la riflessione di questi giorni venga approfondita, fino ad arrivare all'ubi consistam, alla roccia solida della comprensione intellettuale, che ci servirà da faro per ritrovare il sentiero della rinascita e della rivalutazione.
Giustamente, parecchi interventi come quello del Prof. Durant e del prof. Bonavia hanno accentuato la distinzione tra globalizzazione e mondializzazione, un concetto meno controverso e più accettabile. Ma in inglese la parola "mondializzazione" non esiste, forse perché il concetto ha una connotazione culturale e sociale che contrasta con il sentire concreto e pratico del pensare anglosassone.
In contradistinzione alla "mondializzazione", il referente etimologico di globalizzazione e' la territorialità, la materialità del terreno come base concreta dell'unita' umana, la terra firma, l'ubi consistam fisico e primordiale dell'esperienza umana, l'humus dal quale ha origine tutto il genere umano in senso biblico e in senso biologico.
In una brillante esemplificazione paradigmatica, il prof. Giordano ci ha illustrato la connessione e la continuità tra sistema cartografico territoriale romano, come base concettuale e operativa della globalizzazione dell'impero, e i sistemi cartografici contemporanei.
Il territorio e' l'essenza dell'economia. La globalizzazione comincia non dalla cultura, ma dal territorio e dalla capacità di trasformare e di interscambiare la materia. La globalizzazione in atto e' una splendida conferma della teoria del "cultural lag" enunciata 80 anni or sono dal sociologo William F. Ogburn, secondo il quale l'innovazione tecnologica invariabilmente precede di parecchi decenni l'innovazione culturale e la trasformazione dell'ordinamento sociale.
La stessa Chiesa Cattolica ha sempre fatto distinzione tra il "mundus", che comporta una connotazione peggiorativa (evocando mondanità e peccaminosità) e l'orbis, il globo, l'etimo preferito nel momento pratico-amministrativo ecclesiastico.
La Chiesa e' testimone della prima globalizzazione fisico-territoriale, tentata e fallita. Da secoli la Chiesa reclama per se stessa "totus orbis terrarum" (sarebbe più corretto dire "totum orbem terrarum"), avendo diviso amministrativamente tutto il globo in diocesi e parrocchie, sicché oggi non c'e' un metro quadrato del "globo", sia pure in Cina, nell'Arabia Saudita o in Siberia, che la chiesa non consideri (paradossalmente) "suo territorio spirituale", sul quale esercitare "giurisdizione ecclesiastica".
Da secoli, quindi, la Chiesa ha capito il valore di definirsi come globale, territorialmente, prima che socialmente e culturalmente, cioè come mondiale. (I due concetti, poi, si fondono e trascendono nel concetto di Ecclesia Universalis, con la quale espressione la Chiesa cerca di proiettare una dimensione intergalattica)
Ma allo stesso tempo la Chiesa ha sempre cercato di adattarsi alle varie culture (acculturazione), appunto nello sforzo di diventare mondiale, come si evidenzia dalla famosa diatriba sui culti cinesi e come dimostra la prof.ssa Maria Cristina Esperanza Barron Soto nel suo saggio sul tentativo di cristianizzazione del Giappone, tentativo che lei definisce un evento precursore della globalizzazione.
It territorio, questa terra che calpestiamo ogni momento e che ci nutre ogni giorno, condiziona e definisce la nostra umanità. E lo fa in modo unitario, inesorabile, egalitario. Al contrario della cultura, il territorio e' continuo e coerente, anche se svariato nelle sue panoramiche. Siamo noi con la nostra cultura a differenziarci, a immaginare confini che definiscono "nazioni", "tribù", "etnie", "proprietà private" e alterità artificiali.
Gli scolastici medievali per sostenere la nozione di una legge "naturale" svilupparono la famosa tesi: "quod ab omnibus, semper et ubique?." Le grandi esplorazioni e scoperte del Rinascimento mettevano in evidenza la falsità antropologica e geografica della tesi scolastica, un fatto che spinse Montesquieu alla ricerca dei correlati sociali e fisio-geografici delle leggi delle genti e della emergenza delle norme nella societa', preludendo così all'emergere delle scienze sociali.
Forse e' venuta l'ora di riprendere il discorso sull' "ab omnibus, semper et ubique". Potremmo affermare in tono faceto che solo con riferimento a CocaCola, CNN, blue jeans e pizza oggi si può parlare genuinamente di "ab omnibus, semper et ubique"?. Ma, in vena piu' seria, potremmo dire che questa nozione, finora utopica e presuntuosa, può costituire la base di un umanesimo universale che dall'umanesimo latino prenda l'abbrivo e il fondamento.
Sono perfattamente d'accordo con il prof. Paviani quando suggerisce che dall'umanesimo latino potrebbe emergere la spinta verso una "macroetica planetaria" che aiuti a risolvere i problemi sempre crescenti dell'alterità.
Il problema dello sviluppo di un umanesimo universale ha il suo addentellato nell'ambiguità' fondamentale della "natura umana", allo stesso tempo capace di identità e di differenziazioni profonde, e sempre drammaticamente tormentata dal problema dell'alterità. Questo conflitto tra universalità e particolarismo e' messo in risalto molto chiaramente dall'intervento del prof. Bernardi.
Il timore espresso in quasi metà dei saggi allestiti per questo convegno si riferisce alla paura che la globalizzazione finisca con il livellare necessariamente le differenze culturali e annullare le identità regionali.
Ma allo stesso tempo si intravede in buona parte degli interventi la speranza (anche se incredula e debolmente convinta) che la globalizzazione possa effettuare un rafforzamento delle diversità, un accorciamento delle distanze intercomunitarie, o almeno una mosaicizzazione delle varietà etniche, culturali e sociali del mondo.
Il prof. Gabriele Orcalli ha dimostrato con chiarezza la compatibilità, anzi i vantaggi, della persistenza della cultura locale, anche nel contesto della globalizzazione delle relazioni economiche, mentre il prof. Ino Rossi arguisce che sarebbe errato considerare il rapporto tra valori umanistici e il processo di globalizzazione come un rapporto antitetico.
E fa piacere sentire il senso positivo del documento del Gruppo Giovani UTRIM-ULM, nel quale si esprime la convinzione, squisitamente giovanile, che le nozioni di Umanesimo Latino, globalizzazione, gioventù ed emigrazione possono essere conciliate ed armonizzate.
Da una analisi più approfondita degli interventi, quindi, si evincono e delineano gli elementi essenziali della metodologia da seguire per arrivare all'obiettivo desiderato di identificare quale contributo positivo e duraturo il movimento umanistico latino puo' dare a una società in via di globalizzazione.
Il primo passo che va fatto e' liberarsi della nostra inclinazione atavica, rintracciabile al virus dualistico manicheo (che sopravvive ancora nel nostro DNA latino) di demonizzare, cioè, quello che ci sgomenta con la sua novità, perché cambia i parametri di comportamento e i nostri codici profondi culturali, come direbbe Levy Strauss.
Per facilitare questo movimento liberatorio occorre che ci avventuriamo in una analisi precisa, anche se penosa, delle colpevolezze, manchevolezze e debolezze storiche dell'umanesimo latino, così come si e' venuto sviluppando nei secoli. Come si esprime la Dichiarazione del Gruppo Americo-Latino, occorre "esorcizzare" l'umanesimo latino dei suoi errori storici.
Alcuni interventi, come per esempio il rapporto continentale per l'Africa della prof.ssa Elvira Mea, hanno elucidato questo punto con allusioni chiare alle conseguenze della colonizzazione, della mancanza di concretezza, dell'incoraggiamento del nazionalismo e del tribalismo che a volte hanno accompagnato l'esperienza latina, specialmente quella coloniale che ha esasperato condizioni locali gia' poco desiderabili.
Molto lavoro resta ancora da fare in questo settore: per conoscerci meglio, per riconoscere gli errori collettivi in cui siamo incappati e per darci il necessario senso di umiltà e di curiosità di fronte ad altri umanismi.
Il giusto ridimensionamento dell'umanesimo latino e' un dovere etico per tutti noi.
Ma il compito più ingrato sarà quello di identificare e superare soprattutto le ambiguità e le "contraddizioni interne" dell'umanesimo latino, come giustamente suggerisce il prof. Jaime Paviani.
Ne cito alcune:
1. Una prima ambivalenza, generata dalla cultura umanistica latina e' attribuibile precisamente alla nostra nozione della centralità dell'uomo, un concetto che facilmente sconfina in quello della superiorità dell'uomo sulla natura, che va dominata e sfruttata per il bene esclusivo dell'umanità' sia in funzione della salvezza, sia in funzione di una presunta missione ricevuta da Dio.
A parte l'intervallo del Romanticismo, non troviamo nella tradizione umanistica latina un filone solido di apprezzamento, di inclusione e di rispetto della natura, dell'ambiente, della terra, della vegetazione, delle specie animali, ecc. La concettualizzazione dualistica spirito-materia ci condiziona, come esseri "spirituali", a un atteggiamento di superordinazione a tutto quello che e' materiale e fisico. Nascosto nei meandri dell'umanesimo latino c'e' un senso di anti-materia, che tocca non solo elementi umani fondamentali, come cibo, vestito, abitazione, ma anche tutto quello che e' natura, quantificazione e tecnologia.
Oggi il diffuso e dominante sentimento ecologico e la nuova coscienza ambientale della societa' ci costringe a riflettere con più umiltà ed ecumenicità sulla nostra dipendenza dalla "terra" e dalla "materia" e ci costringe a un nuovo atteggiamento di rispetto per la natura e per il mondo fisico come componenti integranti della nostra umanità.
Per di più l'ambiente, il clima, l'inquinamento, i disastri naturali sono di loro natura "globali", e pertanto spesso irriducibili al controllo delle forze culturali, nazionali e/o internazionali, come e' il caso della "ozone layer" o del riscaldamento terrestre. Conclude giustamente il prof. Alejandro Lopez Lopez: la questione ambientale e' al centro della globalizzazione.
Ancora una volta, la Dichiarazione Latino-Americana richiama questo problema, auspicando il ritorno all'armonia tra esseri umani e natura, nell'umile accettazione dei limiti di uno sviluppo sostenibile.
Ma la nuova coscienza ambientalista comporta anche un ripensamento del nostro atteggiamento verso la "tecnologia" come strumento di conoscenza e di controllo degli elementi naturali, un esercizio umano che non ha nulla da invidiare alle arti, alle lettere e alla cultura e che può persino essere fonte e contesto di esperienza mistica.
2.Il concetto di "popolo eletto", o popolo con un "destino manifesto", superiore agli altri popoli (versione romana: tu regere imperio populos, romane, memento!).
E' vero che troviamo questo concetto anche in contesti non riducibili alla cultura umanistico-latina, come nell'antico Egitto, tra i Maia, nel Giappone e, in misura minore, in Cina; ma quello che conferisce drammaticità e' che la versione latina del concetto affonda le sue radici nella tradizione biblica, e' stata per secoli patrimonio dei Cristiani occidentali, cattolici prima e protestanti poi, e ha assunto una forma politico-deteriore in nazioni come la Russia, l'Inghilterra, la Francia, la Germania nazista, e oggi gli Stati Uniti.
Le conseguenze di questa ideologia sono state sempre drammatiche per l'umanità', soprattutto nella forma di guerre etniche, specialmente contro e tra i popoli colonizzati, come sostiene la prof.ssa Elvira Mea. Non ci può essere pace e tranquillità nel mondo finche' questo concetto non verrà estirpato dalla società.
Tutti i popoli sono popoli eletti, perché eletta e' l'umanità' nella sua totalità. In un sistema globale non c'e' spazio per un settore che si autodefinisca, sia pure su base religiosa, politica, culturale o capitalistica, "popolo eletto", riducendo per inteso tutti gli altri alla condizione di "non-eletti".
3.Il concetto dell' appartenenza territoriale.
Qui l'ambivalenza e' ancora piu' pronunciata, perché troviamo nelle ordinazioni giuridiche latine la difesa piu' netta della correttezza della proprietà privata e dell'appartenenza territoriale (ricordiamo la forza politica e giuridica del "civis romanus sum"). Ma allo stesso tempo nell'umanesimo latino si fa strada una concezione cosmopolita del rapporto uomo-territorio. "Patria est ubi bene vivitur", dicevano gli antichi Romani; più tardi Erasmo di Rotterdam si promulgava "cittadino del mondo" secoli prima dell'Unione Europea, come ci ricorda il prof. Acilio Da Silva Estanquiero Rocha.
E non va dimenticato il fatto che storicamente dei circa 150 milioni di persone che dal 1500 sono emigrati in regioni del mondo a volte agli antipodi della loro terra natale, oltre la meta' provenivano da paesi latini. L'emigrazione e' un fenomeno territoriale, che legalmente rompe e ricrea il rapporto tra essere umano e territorio anche nella sua connotazione di proprietà privata. Il diritto all'emigrazione implica il diritto al possesso potenziale di un territorio sul quale non si e' nati. Questo punto e' stato illustrato molto bene, anche se indirettamente, nel saggio del prof. Alejandro Lopez Lopez.
L'implicazione qui e' che il rapporto terra-uomo non comporta esclusivamente particolari individui o gruppi, ma può cambiare padronanza, a seconda dei tempi e dei contratti sociali. Basta riflettere al conflitto decennale tra Ebrei e Palestinesi per il controllo della Judea/Palestina. Nello stato di Washington da qualche anno va avanti una diatriba giuridica sull'appartenenza dello scheletro di un abitante di oltre 10.000 anni fa ritrovato in quel territorio, la cui fisionomia non e' riportabile agli Indiani del Nord America (Pellerossa), ma a un altro gruppo genetico sconosciuto che occupava quel territorio prima dei Pellerossa.
I grandi gruppi multinazionali oggi avanzano il diritto sui proventi di terre lontane dai loro headquarters, in base al prevalere del diritto di "gruppo" e della corporazione commerciale-industriale sul diritto individuale e nazionale, come illustra chiaramente il saggio del prof. Manuel Augusto Rodrigues.
4. Il quarto dilemma da risolvere e' quello dei solipsismi, il solipsismo accademico disciplinare e il solipsismo culturale.
Piero Giorgi ha illustrato in modo convincente la necessità di impostare lo studio e la rivitalizzazione dell'umanesimo latino con unametodologia comparata e interdisciplinare. Il Prof. Fang Litian ha sintetizzato brillantemente lo sviluppo storico dell'umanesimo cinese nel codice di comportamento nelle quattro relazioni fondamentali dell'uomo, con se stesso, con gli altri, con la nazione e con la natura. Questo assaggio di umanesimo comparato ci fa capire quanta strada ci resta da percorrere se vogliamo avventurarci sul cammino necessario per capire il senso comune dei tanti umanesimi che hanno animato le nazioni, da quello cinese a quello islamico, a quello africano, illustrato nei saggi di alcuni dei nostri delegati portoghesi, a quello slavo, a quello indiano e giapponese.
Arriverei a dire che oggigiorno l'unica vera giustificazione per rilanciare l'umanesimo latino e' precisamente quella di conferirgli un ruolo leader nella creazione dell' UMANESIMO (scritto a lettere maiuscole) che non e' piu' ne' latino, ne' anglosassone, ne' islamico, ne' cinese, ma la sintesi e la perfezione di tutti questi umanesimi, che si ritrovano nel concetto fondamentale di umanità.
Quindi il superamento della nostra tentazione solipsistica esige che, nel riscoprirci latini, e per riscoprirci latini, dobbiamo prima riscoprirci umani, vicini e condividenti di tutta l'umanità' con tutti quelli che l'umanità' condividono con noi.
5. L'ambivalenza linguistica. E' sintomatico che per questo convegno il Presidente De Poli ha preferito non far ricorso alla traduzione simultanea. Indubbiamente, questa decisione ha creato qualche disagio a qualche delegato. Ma ci sostiene l'esperienza dei convegni precedenti sull'Umanesimo Latino che hanno espresso con successo una condizione paradigmatica. Se siamo tutti oriundi latini, dobbiamo ritrovarci attraverso il nostro ceppo linguistico, non attraverso mediazioni estranee. Lo sforzo di capirci avalla e compensa lo scomodo di dover fare attenzione all'alterità linguistica che si basa e scaturisce dalla nostra identità umanistica.
D'altra parte non possiamo farci illusioni. Le lingue sono esperienze di vita, che nascono e muoiono. Come strumenti di comunicazioni, le lingue (non solo il latino e il greco, ma anche lo spagnolo, il portoghese, l'italiano e il francese) hanno funzioni fondamentali, ma limitate e transitorie. Una breve analisi storica ci dice che tutte le lingue, come tutte le religioni, fanno il loro tempo, si trasformano e scompaiono. Il prof. Corsaniga esemplifica questo processo con quanto sta succedendo precisamente alla lingua dominante, l'inglese.
Non possiamo immolarci per sempre sull'altare della melanconia linguistica. Quello che conta e' la continuazione genetica della capacità di comunicazione attraverso la lingua, o le lingue, piu' adatte al processo stesso di comunicazione e di identificazione.
Un aspetto essenziale dell'umanesimo latino e' la sua cattolicità nel senso che e' legittimo attendersi che una persona formata nella tradizione umanistica latina non solo conosca piu' lingue, ma soprattutto sappia comunicare efficacemente in qualsiasi lingua conosca.
Sono rimasto molto impressionato dal saggio del prof. Vo Xuan Que sulla funzione rivoluzionaria della romanizzazione dell'alfabeto vietnamita, specialmente quando si riflette, per contrasto, sulla vicenda peculiare del ruolo del latino nella carriera di Pio II, al secolo Enea Silvio Piccolomini, come ha fatto il prof. Konrad Benedikt Vollman. Promoviamo, si, la conoscenza del latino e delle lingue umanistiche, ma non al punto di dimenticare che la funzione della lingua e' prima di tutto universalizzante, permettere cioè maggiore comunicazione anzicchè particolareggiante, arginare distinzioni e distanze sociali.
Valentina Napolitano illustra brillantemente la latinità del genio inglese di Shakespeare, che pur non avendo mai visitato l'Italia, riesce a riempire di italianità gran parte dei suoi personaggi e fare questo in un inglese che riproduce tutta la nobiltà del sentire classico umanistico, fino alla metrica perfetta dell'endecasillabo adattato alla fonetica anglosassone.
6. E finalmente il dilemma politico-economico. La globalizzazione suona le campane a morto della nazione come concetto aggregante su base territoriale, linguistica e storica e soprattutto economica. Fin dal suo esordio otto secoli fa, la nazione e' stata l'istituzione di riferimento per l'azione economica, politica e amministrativa dell'occidente. Ma oggi e' in atto un processo di graduale esautorazione della nazione, specialmente ad opera delle forze economiche e globalizzanti. Quello che la politica e la religione non sono riusciti a fare, l'economia sembra capace di effettuare nel corso di pochi decenni: trascendere la nazione come referente principale del gruppo. Benché le nazioni abbiano avuto un ruolo positivo, esse sono state nondimeno gli attori principali e quasi esclusivi delle più distruttive esperienze umane: le guerre. Non che la scomparsa delle sovranità nazionali necessariamente significhi la fine dei conflitti. Ma certamente in una società globalizzata potranno e dovranno essere inventati nuovi ed efficaci meccanismi di controllo della conflittualità collettiva e della competitività tra gruppi.
La spinta economica, che cinque secoli fa' motivo' i grandi navigatori e che oggi anima le multinazionali e accomuna i gruppi di interesse al di la e al di sopra di appartenenze nazionali, e' oggi la forza maggiore nel processo di globalizzazione e di superamento della "nazione". Ma e' la stessa economica che sente il bisogno di un ricompaginamento della netta separazione che per decenni l'ha circoscritta in un ambito esclusivo di razionalità, per ritrovare il suo rapporto con l'esperienza umana e la sua relazione imprescindibile con l'etica.
Da questo punto di vista l'umanesimo latino si trova in una posizione vantaggiosa, sia perché ha sempre promosso le arti e le attività proprie di regimi di pace, sia perché l'umanesimo latino (con la notevole eccezione del recente intervallo fascista in Italia e in altre nazioni) non ha esaltato il militarismo nella misura seguita da altri umanesimi (come l'Islam, il Nazismo, il Regime imperiale Nipponico, i regimi Marxisti, ecc.).
Guardando il futuro
Quali possono essere, quindi, le direttrici per il cammino futuro di questo "movimento"'
Con riferimento specifico al movimento latino umanistico in atto, vorrei suggerire quattro progressioni che andrebbero effettuate:
1.Dalla Mobilitazione alla Istituzionalizzazione.
2.Dalla Parrocchia latina al Globo multiculturale
3.Dal momento Umanistico-artistico al momento Interdisciplinare e Interpolitico.
4.Dalla retorica alla sostanza.
1. Dalla mobilitazione alla Istituzionalizzazione.
Il lavoro fatto finora ha acquisito al movimento considerevole visibilità e maturata nel corso dei precedenti sei convegni internazionali. La crescita incrementale del movimento richiede che si passi ora dal momento convegnistico mobilitante e sensibilizzante al momento istituzionalizzante e operativo. Il programma del proposto Centro Interuniversitario di Studi e di Iniziative attorno ai Valori dell'Umanesimo Latino con sede a Treviso e a New York e' una prima, efficace risposta a questa esigenza, con possibilità di espansione e di coordinamento globale a rete.
2. Dalla parrocchia latina al globo multiculturale. Il movimento deve passare dal momento focalizzato sulla comunità latina nel mondo al momento ecumenico interumanistico e interculturale, per includere i grandi umanesimi che al momento animano la maggioranza della popolazione del globo. Il prof. Gilardino nota giustamente che il nostro interlocutore primario oggi e' rappresentato dall' umanesimo anglosassone, che fa da propulsore alla globalizzazione. Ma, come già facevo presente nei miei interventi di Treviso e Tolosa, e' indispensabile aprire il discorso anche con la ricca tradizione dell'umanesimo islamico, cinese, africano, slavo, giapponese e indiano.
Parafrasando il professor Ferruccio Bresolin, direi che, per l'umanesimo latino, dopo il passaggio storico dal paradigma mediterraneo al paradigma atlantico e' venuta l'ora di passare al paradigma mondiale.
3.Dal momento umanistico al momento ecumenico, interdisciplinare e interpolitico.
Finora il discorso dell'umanesimo latino e' stato mandato avanti soprattutto da umanisti, scienziati sociali e associazionisti. Occorre avanzare dal momento associativo e umanistico al momento interdisciplinare e politico, coinvolgendo nel dialogo i maggiori esponenti delle scienze economiche, manageriali e politico/giuridiche, nonché i leaders politici nelle nazioni con una forte presenza demografica latina.
Sono questi i principali responsabili di quello che il prof. Durand definisce come "il deficit antropologico" della società contemporanea.
4.Dalla retorica alla sostanza
Per noi latini la retorica e' allo stesso tempo gioia, esaltazione e rovina. La retorica e' facile e spontanea e può offrire intense soddisfazioni estetico-auditive. Ma e' il meccanismo della inattivita' e dell'auto-esaltazione, pur creando l'impressione che qualcosa accade: 'tamquam aerem verberans...?' (volgarmente: aria fritta).
La sostanza, d'altra parte, significa programmi di ricerca, corsi universitari, pubblicazioni, scambi di idee con studiosi di altre discipline e soprattutto impatto sui programmi politici e sulle decisioni economiche. Questo richiede che noi riusciamo a dare risposte chiare ed efficaci ai due quesiti fondamentali che ci siamo posti in questi giorni:
a)come si salvaguardano le diversità culturali nella inevitabile omologazione della società globalizzata e
b)come si intavola e sostiene il dialogo ecumenico tra i vari umanesimi per la creazione di un UMANESIMO, sic et simpliciter, senza aggettivi restrittivi e qualificanti, servendosi del potere comunicativo della globalizzazione?
Conclusione
A conclusione di questo convegno e di questo saggio riepilogativo vorrei che ci dessimo un appuntamento. L'appuntamento che ci diamo non e' per un altro convegno e non ha ne' data ne' luogo. E' invece in appuntamento inglobante.
L'appuntamento dovrà essere mantenuto ogni giorno, nel corso delle nostre lezioni, delle nostre pubblicazioni, delle ricerche che conduciamo e perfino dei contatti umani che intratteniamo con i nostri studenti e i nostri colleghi di università. L'appuntamento comporta la sfida di ritrovarci, sentirci e comportarci secondo le aspettative della nostra tradizione plurimillenaria, secondo i canoni più squisiti della cultura umanistica latina e alla ricerca del rilancio di quello che ha costituito l'essenza di essere latini fino ad ora.
E' un appuntamento che ha a che fare con il nostro modo di pensare di noi stessi, di comportarci con le alterita', di apprezzamento di quello che abbiamo ereditato.
E' un appuntamento senza limiti territoriali o temporanei, senza complessi e ambivalenze e senza etnocentrismi. E' un appuntamento con noi stessi che, alla fine del giorno ci permetta di allitterare il detto di Terenzio "homo latinus sum, nihil humani a me alienum puto"; che tradotto suona: 'Il mio essere latino mi arricchisce solo se arricchisce allo stesso tempo tutta l'umanità'.